«Quando si svegliava in mezzo ai boschi nel buio e nel freddo della notte allungava la mano per toccare il bambino che gli dormiva accanto. Notti più buie del buio e giorni uno più grigio di quello appena passato. Come l’inizio di un freddo glaucoma che offuscava il mondo»
Inizia così “La strada” di Cormac McCarthy che immediatamente ci riporta a noi e al tempo stressante e doloroso che stiamo vivendo. Non facciamo infatti in tempo a uscire dallo stato di emergenza che ci ritroviamo a fare i conti con una guerra, neanche così lontana da poter dire «non mi riguarda». Siamo presi alla sprovvista, sgomenti, messi a dura prova. E non è possibile non vedere che tutto quello che sta accadendo ha un impatto emotivo su di noi e non accorgerci che abbiamo bisogno di prenderne atto e di condividere. Certo, una parte di noi vorrebbe andare avanti, dimenticare, bypassare, tornare a come era prima: è la via della fuga, della dimenticanza. “Parliamo di cose positive”, “cambiamo discorso”, “andrà tutto bene”: così parla il linguaggio della fuga, usato chissà quante volte. È una reazione naturale immediata, ma a lungo andare non ottimale. Perché?
Perché la dimenticanza, l’evitamento alla lunga si rivelano inefficaci. Ce lo dimostra la psicoanalisi, ma anche la storia: quello che teniamo taciuto, fuori dalla porta, continuerà a bussare, finché non le daremo udienza. Lo stato di emergenza, ancora una volta e in maniera dura, ci insegna che la via da percorrere è quella della consapevolezza, dell’inclusione/integrazione e della condivisione. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di sapere quello che ci sta capitando e di condividerlo. Solo così possiamo sollevarci dallo sconforto e sentirci più in equilibrio, più capaci di gestire la situazione.
La pandemia con il suo essere inaspettata, inattesa, inimmaginabile, è stata ed è a tutti gli effetti un evento traumatico (trauma collettivo). Come tale ha creato un vero e proprio taglio tra un prima e un dopo (la vita come era prima non c’è più) e ha rotto la bolla di illusione in cui eravamo (il mondo è un luogo sicuro, tutto è sotto controllo) costringendoci a un risveglio amaro dal sonno (il mondo non è sicuro come credevo, non tutto è sotto il mio controllo). Questa è una ferita. Una ferita innanzitutto depressiva, in quanto è esperienza di lutto (il mondo di prima non esiste più) e allo stesso tempo una ferita infantile-narcisistica (il mondo che credevo sicuro/di cui mi fidavo è invece insicuro, fragile, imperfetto e per di più io non posso vincere niente e nessuno per farlo tornare perfetto). Di questa ferita dobbiamo prenderci carico.
C’è poi chi ha vissuto sulla propria pelle, oltre all’isolamento e alla restrizione della libertà, la malattia o la morte di persone care, lutti complicati dall’impossibilità di salutarsi, di compiere quei rituali necessari per metabolizzare la separazione. In questi casi, al lutto per il mondo come lo conoscevamo prima e che non c’è più, si è aggiunto il lutto per la perdita degli affetti in carne ed ossa o la caduta della propria salute (trauma soggettivo).
L’emergenza insomma ci sta costringendo a fare i conti con l’incertezza, l’imprevedibilità, il cambiamento, tutto quello con cui di solito non vogliamo confrontarci. Ci ha colto un po’ come bambini indifesi di fronte allo sconosciuto, facendoci sperimentare la paura. Quasi a riportarci indietro nel tempo, alla paura del buio o alla “paura dell’estraneo” di quando eravamo piccini. Che in fondo altro non è che paura dell’ignoto.
E allora, come fare?
Prenderci carico della ferita vuol dire per prima cosa prendere coscienza del senso di impotenza, della fragilità che sentiamo o abbiamo sentito sulla pelle. Non dobbiamo nascondere quello che proviamo, fare finta di niente o vergognarci della nostra vulnerabilità, ma piuttosto accogliere, sostenere e comprendere. Significa poi raccogliere i cocci, ricomporre i pezzi, ma in una forma nuova, creativa. Se tutto quello che ci succede ha un senso infatti, le cose non devono tornare come prima, ma bisogna compiere una trasformazione evolutiva, un salto quantico creativo. Se le esperienze dolorose, traumatiche, le “crisi”, possono avere un risvolto positivo, come ci insegnano psicologia e spiritualità, questo è che trasformino, cioè ci facciano diventare uomini e donne nuovi, più maturi, più umani. E questo io credo possa avvenire passando dalla via separativa alla via integrativa.
Come ha detto chiaramente lo psicoanalista Massimo Recalcati (*): «Non tornerà il mondo come prima. Dovremo convivere con il virus, dovremo rinunciare alla fantasia infantile-narcisistica che riprenderemo con la sconfitta del virus. Non vinceremo nessun nemico. Noi pensiamo di scindere il bene dal male, il giusto dall’ingiusto, e invece saremo costretti a vivere con la paura e con il coraggio allo stesso tempo, a vivere con la luce e con le tenebre allo stesso tempo. Non possiamo dimenticare, eliminare la paura, ma semai dovremo confrontarci con la nostra paura, facendo in modo che non ci pietrifichi».
La paura ha mille volti, come quello dell’odio, della rabbia, del giudizio e ha tempistiche tutte sue: spesso esce dalla tana di notte, quando siamo più indifesi e non ci fa dormire, ci sorprende all’improvviso per un evento apparentemente banale (come il dover prendere un aereo, allontanarsi da casa, separarsi dal coniuge) o ancora si presenta come uno stato di allerta generale ( la paura che succeda qualcosa di brutto). In tutti i casi ci ripropone, sotto mentite spoglie potremmo dire, il senso di minaccia che abbiamo vissuto.
Per non bloccarci o pietrificarci occorre scendere nelle nostre profondità dove sta il serbatoio più prezioso per il nostro benessere: il Sé, sorgente di risorse inimmaginabili. E da lì che possiamo trarre il coraggio per sostenere la paura, senza per forza eliminarla, attingere la forza per sostenere la vulnerabilità, senza negarla, contattare la luce per sostenere le tenebre, senza evitarle. Questo mi sembra il cuore della questione. Se vogliamo realmente prenderci cura di noi e riassestare la terra che si è smossa sotto i piedi, dobbiamo compiere un lavoro dentro di noi attingendo alle risorse che abbiamo, al bene dentro di noi (ricordiamoci che “coraggio” significa “ritornare al cuore”) e fuori di noi, per non perderci, per non farci schiacciare dalle forze distruttive. È una cura ri-costituente, ri-generativa che ci serve e che ci permetterà di diventare individui più “integri”, capaci di assimilare tutte le parti in gioco.
Tornando a “La strada” di McCarthy, padre e figlio si trovano a compiere un viaggio post-apocalittico attraverso un mondo ridotto a cenere, paurosamente svuotato e inutile, alla disperata ricerca di una via di uscita:
«Ce la caveremo, vero, papà?
Sì, c’è la caveremo.
E non ci succederà niente di male.
Esatto.
Perché noi portiamo il fuoco.
Sì perché noi portiamo il fuoco»
È un un grande passo e una grande responsabilità, un salto evolutivo soggettivo e collettivo allo stesso tempo. “Portare il fuoco”, qui inteso come stare nella speranza, tornare alla forza del bene per sostenere la sofferenza, richiede una scelta e un impegno costanti.
Chiediamoci per esempio: quali risorse sono riuscito a tirare fuori in passato e quali sto riuscendo a tirare fuori in questo momento difficile? Ognuno di noi, come ci insegna chi lavora con le persone colpite da situazioni fortemente stressanti, proprio in queste occasioni riesce a tirare fuori risorse impensate. E poi, cosa mi sta insegnando questo tempo? Cosa ho scoperto di me che prima non sapevo? Quali porte sto aprendo? Io per esempio ho riscoperto il contatto con la natura, il piacere di scrivere e il coraggio di condividere, una mia amica si è impegnata ad aiutare gli altri. Rintracciamo queste risorse dentro di noi e manteniamole accese, alimentiamole, proprio come un fuoco. Sono la nostra forza. E in ultimo condividiamo, chiediamo aiuto quando necessario o rendiamoci utili, anche solo con un piccolo gesto, scambiandoci quello che stiamo imparando. Naturalmente sempre secondo le nostre inclinazioni e ricordandoci che fare qualcosa per qualcuno, fa bene a chi lo riceve, ma prima di tutto fa bene a noi. Abbiamo bisogno di connessione e di sentirci utili per sollevarci dallo sconforto.
Ecco allora quello che mi sta insegnando l’emergenza. In sintesi, l’importanza di tre pilastri:
- Comprendere-prendere coscienza: cosa succede dentro di me (ho paura, mi sento vulnerabile, ecc.) e fuori di me (il senso degli accadimenti);
- Sostenere-essere: imparare a sostenere le emozioni difficili senza evitarle e integrare nella mente/cuore gli eventi dolorosi, anche quando ci sembrano incomprensibili;
- Condividere-agire: esprimere e scambiare esperienze, chiedere aiuto quando necessario o rendersi utili per gli altri
Concludo con le parole di McCarthy:
«Si fermarono nel vento che veniva dal mare, mano nella mano, l’erba che sibilava tutto intorno. Dobbiamo andare avanti, disse l’uomo. Forza.
Non ci vedo.
Lo so. Facciamo un passo per volta.
Ok.
Non mi lasciare la mano.
Ok.
Qualunque cosa succeda.
Qualunque cosa succeda»
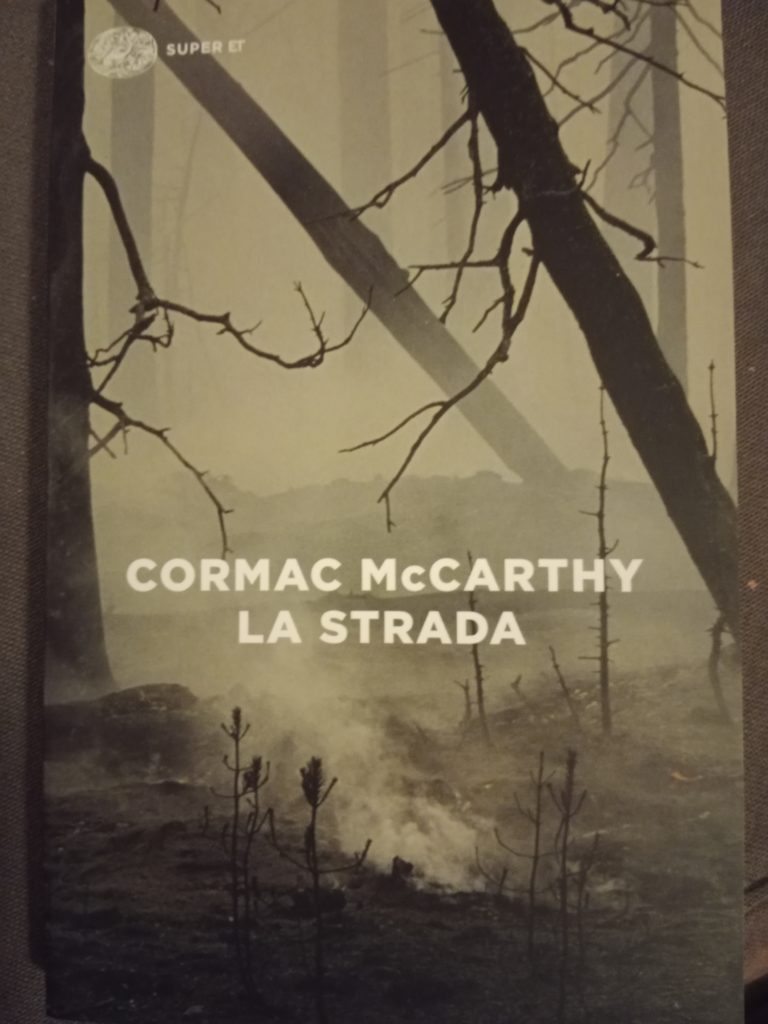
Giorgia Fantinuoli Psicoterapeuta
giorgia.fantinuoli@gmail.com
Cell: 333.2001678
BIBLIOGRAFIA E CITAZIONI
- Cormac McCarthy, The Road, Einaudi, 2006
- (*) M. Recalcati, citazione tratta dall’intervento “Angoscia e audacia al tempo del trauma” consultabile sul sito https://www.psicologia.io/
