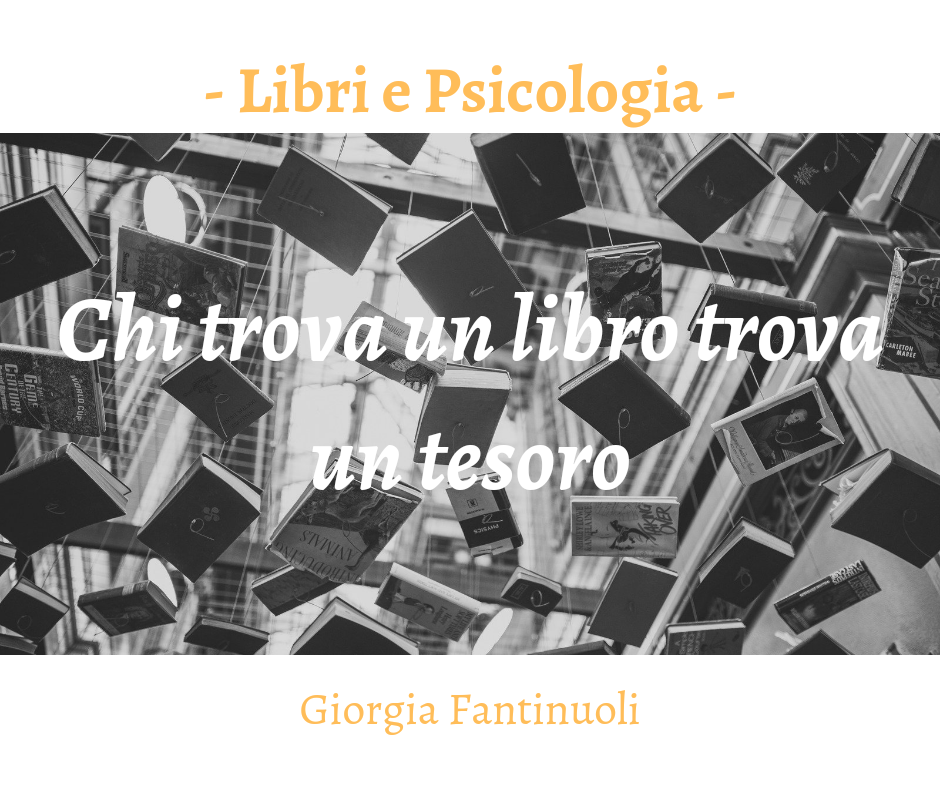«Non avevo amiche. Se qualche debole legame era nato alle elementari, le medie lo avevano spazzato via. Ero timida. Le mie coetanee sfilavano su e giù per via Italia con il rossetto viola e il piercing al naso, parlavano di cose da fare coi maschi che a me suonavano incomprensibili. Non avevo più nonni, né zii o cugini nei paraggi. A differenza di mio fratello non gareggiavo in alcuna squadra. Nessuno mi aveva iscritto a un corso di musica, di teatro. L’unico luogo diverso da casa che frequentavo era la biblioteca per bambini. Prima di diventare la “straniera” a T, nelle scuole di Biella ero stata l’ “asociale”.
Si presenta così la protagonista di Un’amicizia di Silvia Avallone, senza veli, mostrandoci da subito le sue fragilità. Elisa è una che conosce presto il sapore della mancanza: genitori che si separano, il cambio improvviso di regione, città, scuola. Una lacerazione profonda anche quando deve separarsi dalla mamma e dal fratello per andare a vivere con quel perfetto sconosciuto che è il papà. Un vuoto, che cercherà di colmare in qualche modo nella relazione fatale con la bella, perfetta, ammaliante Beatrice che sembra incarnare – in apparenza – il suo alter ego riuscito. Il lettore non può che non riconoscersi in Elisa perché intimamente ogni nostra vita è così: fragile, sconquassata, sempre messa a confronto con qualcosa di irraggiungibile.
Ecco, forse quel che mi è piaciuto di questo romanzo è l’autenticità che traspare, la capacità dell’autrice di farti entrare fin nelle ossa la realtà della vita così com’è, senza sconti, senza illusioni. Forse per questo è attraversato da quel velo nostalgico, quel retrogusto amaro, che è proprio di chi sta facendo i conti con se stesso e con il proprio passato. Oserei quasi dire che la protagonista del romanzo è proprio questa verità che ci riguarda tutti come essere umani in cammino, in quel continuo rapportarci alla quotidianità, ai nostri fantasmi e ai nostri limiti. E infatti tutti i personaggi del racconto alla fine si rivelano per quello che sono, anche quando il sopraggiungere dei social dà loro l’escamotage, l’illusione di nascondersi dietro uno schermo, nel tentativo di apparire perfetti, felici.
Elisa prova vergogna, rabbia e rancore nei confronti di chi l’ha tradita – una madre inadeguata e caotica che da piccolina quando aveva la febbre e non sapeva a chi lasciarla la parcheggiava in una biblioteca, una famiglia “diversamente unita” e “diversamente elegante” la sua, a differenza di quella di Beatrice, che ammira -. Questo senso di essere fuori posto, sbagliata, la porta continuamente a tornare indietro nel tempo, all’infanzia, a quei ricordi che si imprimono nella memoria e che non vanno più via.
Si può rimanere incagliati qui, a questo punto, dentro questo passato e questo turbinio di emozioni dolorose, oppure si può compiere un salto, di maturità, come farà Elisa nel suo percorso di elaborazione lungo tutta la scrittura: realizzando che anche gli altri, papà e mamma compresi, sono fragili, limitati dalle loro stesse ferite; realizzando che la stessa vita è imperfetta e quasi mai le cose filano lisce. E che dulcis in fundo, lei stessa una volta divenuta adulta, non è quel genitore ideale, così tanto diverso da mamma e papà, che si aspettava di essere.
Quello che io trovo cruciale nel cammino di crescita di ciascuno e che ritrovo nelle pagine di questo libro è infatti la scoperta che alla fine siamo un tutt’uno, nel bene e nel male, e che per quanto ce la mettiamo tutta, siamo tutti immersi dentro questo sconfinato mare d’imperfezione – che nessun mondo social può eludere -. E questo ci solleva dal carico di giudizio e dalla rabbia e dal rancore che ci portiamo appresso. La mancanza rimane mancanza sì, la ferita non scompare, certo, ma le aspettative grandiose su di noi, sugli altri e sulla vita retrocedono al passo dell’umiltà. Cosa vorrei dire?
Quante volte ci siamo detti o abbiamo pensato: io non farò come i miei genitori, io sarò meglio, e poi da adulti ci siamo sorpresi con le mani nel sacco esclamando: cavolo, sto facendo esattamente quello che faceva mamma/papà! E se subito è una constatazione amara, con il tempo si addolcisce. Succede cioè che quella distanza, quella ribellione funzionale in adolescenza e in giovinezza, con la maturità lascia spazio a una riconciliazione. Che non è un giustificare, vedere come buono qualcosa che non lo è stato. Questo rimarrà tale, ma significa aprirsi a, assimilarlo, prendermene cura, tanto da poter andare oltre.
Non facile, perché richiede di guardare tutta la verità, di immergersi dentro se stessi e il proprio passato, proprio come fa l’autrice pagina dopo pagina, e di aprirsi ad essa fino in fondo. Aprirsi a quello che siamo. Una riconciliazione prima di tutto con noi stessi e che ci permette di far prevalere il bene rispetto al male, come dice bene Elisa:
Non è stata colpa tua, penso trent’anni dopo. E nemmeno mia. Non è stata colpa di nessuno, se eravamo così sole. «Suonavi proprio bene» le dico, cercando la sua mano. […] Continuiamo a guardare, distrutti e grati, quel filmato amatoriale mezzo rovinato, che nessuno eccetto noi ha mai visto né vedrà mai. Questo segreto, per sola proiezione privata, intima, famigliare. Siamo tre stranieri che si sono intralciati, fatti del male, ma siamo qui adesso, e mi rendo conto che non abbiamo niente da perdonarci. Lo decido io cosa conta di più, alla fine, dentro questa storia. E conta il bene che ci siamo dati”
Non per niente quello della Avallone è un romanzo sull’amicizia. Amicizia, io credo, verso se stessi, verso i propri fantasmi, verso la vita, come approdo cui arrivare.
Ecco che allora… Il punto d’incontro è la fragilità, dove io e te ci incontriamo, come sulla linea dell’orizzonte si incontrano cielo e mare.
©Giorgia Fantinuoli
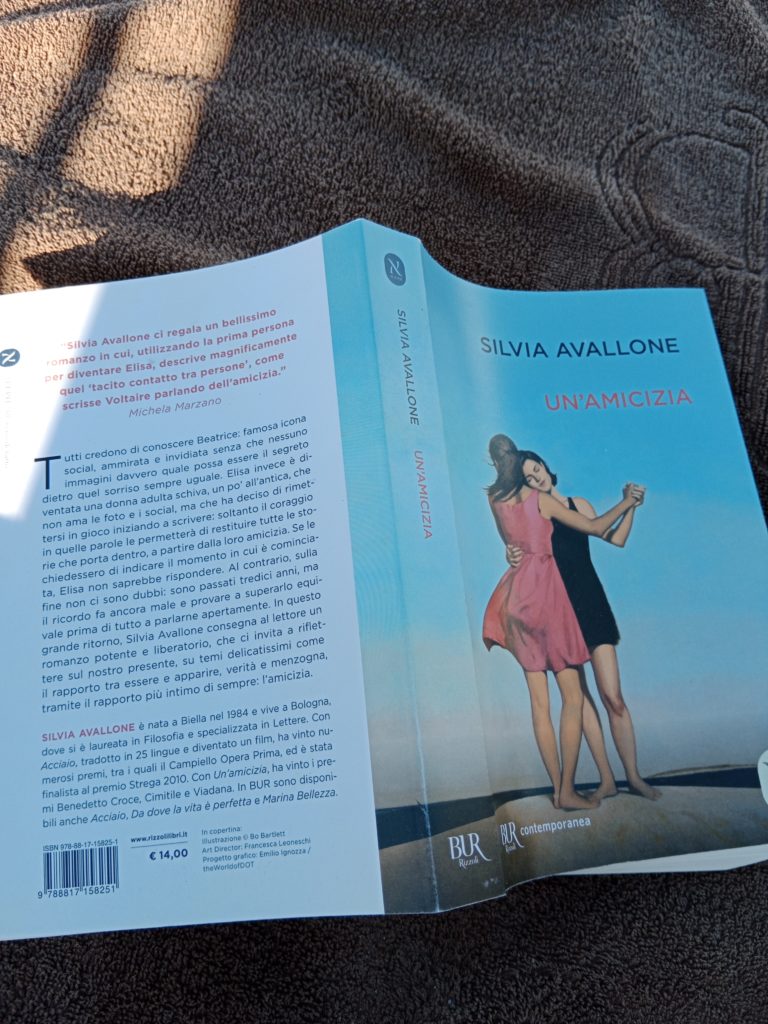
Giorgia Fantinuoli Psicoterapeuta
giorgia.fantinuoli@gmail.com
333.2001678